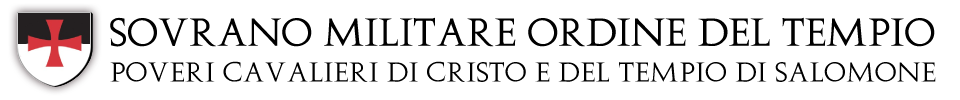(Lorenzo Vita di Il Giornale) – “In finale tiferò Italia”. La lezione di Luis Enrique è quella di un allenatore, e prima ancora di un uomo, che ci riporta tutti con i piedi per terra. In un Europeo invaso da politica, influencer, guerre ideologiche, inchini e non inchini, politicamente corretto e dibattiti sui contagi, l’allenatore della Spagna ferma tutti e ci ricorda una cosa, che quello è calcio. Ed è bellissimo per quello che è: senza sacrificarlo sugli altari della cronaca, delle mode social e del pettegolezzo. Ventidue giocatori che rincorrono un pallone e provano a gettarlo nella rete avversaria cercando di dare spettacolo, che fanno battere i cuori di migliaia di persone nello stadio e milioni davanti a televisioni e radio. Tutto per vivere quel momento: 90 minuti di passione in cui chi vince è l’eroe di una notte e chi perde si lecca le ferite e aspetta la rivincita. Un ciclo continuo che unisce giocatori e tifosi: seguaci fedeli di una religione laica per cui non sono e non saranno mai semplici e tristi follower.
Il calcio può piacere o non piacere. E può anche non piacere quello di Luis Enrique. Non è una scienza perfetta, e solo per qualcuno è una fede fatta di dogmi in cui è impossibile deviare senza essere tacciati di eresia. Ma è bello pensare che non abbia bisogno di lezioni, di moralismi e mode passeggere. Il calcio è tale ed è sempre piaciuto per quello: un mondo a parte con proprie leggi, monumenti, templi, eroi e tradizioni. Non ha bisogno di mode né di influencer, non ha bisogno di lezioni di chi non conosce l’etica dello sport, delle sue regole e anche della sua ferocia popolare. Ci hanno provato a prendere questo mondo e a farlo a immagine e somiglianza dell’altro. Quello grigio finto arcobaleno che ci impongono dove tutto è una guerra e tutto sembra politicamente schierato. Hanno tentato di destrutturarlo e ricostruirlo come un quadro cubista prova a fare con la realtà che ci circonda. Hanno cercato di schiavizzarlo, di costringere questo fiume in argini che non gli competono, snaturandolo e rendendolo privo di anima.
Ma il calcio, nella sua infinita leggerezza e profondità, è riuscito a rovesciare tutto. Anche questa volta. I cori dei tifosi avversari per Christian Eriksen non sono stati incentivati da influencer che passano la vita a fare la morale, ma dal moto spontaneo di migliaia di persone. Sono stati il capitano e gli altri giocatori a circondarlo per coprirlo dagli sguardi indiscreti delle telecamere, comprendendo il dolore prima e meglio di chi vive di finte lacrime. Gli inchini per esprimere cieca fedeltà al Black Lives Matter non hanno impartito lezioni contro il razzismo, perché l’avversario si guarda in piedi, negli occhi, e si rispetta e sfida a prescindere dal colore della pelle. Non sono stati giocatori multimilionari a farci la morale su cosa bere o non bere quando passano la vita da sceicchi grazie agli sponsor.
L’unica vera lezione da imparare la dà un uomo, Luis Enrique, a cui nessuno può dare lezioni di vita. Perché è la vita stessa ad averlo punito col dolore più grande che un uomo possa subire. È lui, l’asturiano alla guida della Roja, a mettere a tacere tutti: si parla di calcio. E il calcio è tutto qui: “Sono felice per quello che ho visto. Ho goduto di una partita di alto livello con due squadre forti che cercavano di giocare un bel calcio, è stato uno spettacolo per i tifosi. Voglio fare i complimenti all’Italia, spero che in finale possa cercare di vincere questo Europeo. Tiferò per gli Azzurri“. Con buona pace di inchini, birre e bibite messe sotto un tavolo, commentatori ideologizzati e moralisti. Grazie Luis.