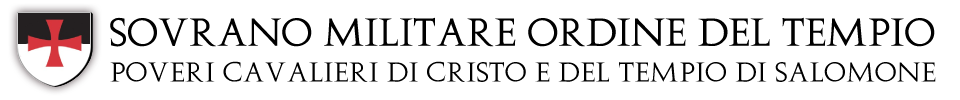(da Positano News) – Riportiamo una bellissima omelia di Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino e per tanti anni parroco a Piano di Sorrento: “Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”. Questa espressione può essere riassuntiva della fede, della speranza e dell’amore che debbono animare la nostra preghiera in questo giorno in cui facciamo memoria grata di tutti i defunti, in particolare dei defunti che abbiamo conosciuto, amato, che ci hanno amato, che ci hanno introdotti nei misteri della vita e nei Misteri della fede. Il credente, pur perdente – è questo l’aspetto drammatico della fede – rispetto all’evidenza, continua a sventolare nei cimiteri, e nel cimitero del suo cuore, questa bandiera della speranza dove è certo di contemplare l’amore di Dio nella terra dei vivi, non in quella dei morti. Anche la nostra visita nei cimiteri, oggi e speriamo non solo oggi perché fa bene visitare i cimiteri di tanto in tanto (è una grande lezione di vita), non dev’essere contrassegnata dalla tristezza, ma dalla danza e dal canto perché, oltre le lapidi, le ossa o le polveri dei nostri defunti ribollono come le botti che preparano il vino da spillare nuovo, buono, segno di condivisione e di festa. Spero che nella fede, ma anche nella sensibilità umana, voi avvertiate questo ribollire delle tombe, dove arde la speranza, dove si consuma, nel senso della lampada, un’attesa che avrà fine, che ha un termine ad quem, cioè verso cui muove. Questo fine è la vita eterna che i nostri defunti già godono, ma che godranno pienamente anche nella dimensione corporea alla fine dei tempi. Quello che noi crediamo per loro, lo speriamo anche per noi, ancora pellegrini nel tempo e nello spazio.
Questa commemorazione dei defunti è innanzi tutto un richiamo a leggere la morte, a farla rientrare nella vita, dal momento che da decenni assistiamo ad una sorta di estromissione della morte dalla vita: è un’operazione culturale che nega la morte, che esalta l’attimo fuggente nel senso deteriore e che esclude ciò che è oltre il presente. Se volete, la nostra cultura si è fermata alla prima parte di quell’inno di vita che ci viene da Lorenzo de’ Medici, quindi da Firenze, che sembra essere un inno pagano: “Com’è bella giovinezza, chi vuol esser lieto sia – e qui si ferma la nostra cultura perché poi continua il testo – di diman non c’è certezza”. Questo rimando al domani – e il nostro domani si chiama morte (non abbiamo timore a dirlo) – non è un’occasione di flagellazione, di depauperamento della vita nei suoi dolori anche più umani, carnali, ma di esaltazione. Riportare – questo è il primo obiettivo nella commemorazione dei defunti – la morte al centro della vita significa sentire che la morte non è nemica: la morte è liberatrice, la morte trasforma gli anziani in giovani, la morte è un inno di libertà. Gli antichi lo ritenevano soprattutto per la morte dei tiranni. Ricordate, nei testi dell’antichità, la morte è indicata come giustizia oltre le false giustizie umane, ma quello che essi cantavano, invocavano della morte del tiranno deve essere per un credente invocato per la propria morte, per la morte in genere, come fonte di liberazione da ogni gravame, per essere pienamente se stessi.
Fratelli e sorelle, noi non siamo ancora noi stessi. Noi diventeremo “noi stessi”, cioè il sogno di Dio all’atto in cui la morte verrà a recidere ciò cui pure siamo affezionati – ed è naturale ed è normale – ma che ci impedisce di volare. La morte, dice il padre della Chiesa Ireneo di Lione, è una sorta di forma di misericordia che Dio ha utilizzato nei nostri confronti perché non ci fosse futuro per il peccato: noi un giorno non peccheremo più e quel giorno sarà senza tramonto, oltre questo giorno che volge al tramonto, brevissimo. Questa dev’essere una prima sorgente di riflessioni e di preghiera in questo giorno. I cristiani, forse da soli, portano ancora avanti il valore della morte come evento, come accadimento umano da celebrare, da preparare, verso cui andare, sia pure adagio come noi umanamente vorremmo.
La seconda considerazione riguarda quelli che prima di noi hanno già compiuto questo esodo e che noi oggi ricordiamo e veneriamo. Non si interrompe la nostra comunione con loro. La fede cristiana è una grande scuola di speranza e di possibilità che si rinsaldino i valori della vita e degli affetti oltre il limitare della morte: la morte non ci separa, la morte ci unisce. Quello che non ci siamo detti in vita, ce lo diremo in morte e ci sono sempre delle cose che noi non ci siamo detti: delle parole dolci, dei gesti di tenerezza. Ogni qualvolta la morte ci sorprende – e la morte ci sorprende sempre – ci nascono dentro tanti rimpianti: “Non ho detto… Avrei potuto… Non ho fatto quel gesto… Non ho creato quella occasione di riconciliazione… Avrei potuto dirle o dirgli ‘ti voglio bene’ e una sorta di pudore mi ha trattenuto…”. Bene, cari fratelli e sorelle, questo non vale per noi, perché anche quelli fra voi che vivono in una ininterrotta comunione si diranno veramente il bene nella morte. C’è un’espressione che riguarda l’ambito educativo, e quindi innanzi tutto i figli, gli alunni e quanti, in qualche maniera, si rapportano a noi come maestri, che mi accompagna da anni e che dice che bisogna attendere in vita e in morte. Il figlio che non è tornato in vita, torna in morte. La moglie che non è tornata in vita, tornerà in morte. La morte diventa veramente la patria dove ci riconosceremo e dove potremo dirci quello che non ci siamo mai detti nei termini belli, costruttivi, edificanti. Questo noi lo possiamo già realizzare nella fede, nei confronti dei nostri defunti. In fondo, tutte le espressioni di affetto e di preghiera possono riassumersi in quella semplicissima frase del nostro vocabolario “Ti voglio bene”. Lo diciamo ai nostri defunti, glielo diciamo con una preghiera, glielo diciamo portando un fiore, un ricordo, forse anche con un rimpianto, ma lenito da questa speranza che ci dice: “Ti ascolta, è con te”.
Non devi più separarti dalla persona defunta: ci si separa dalle persone vive. La persona defunta è con te (non è certamente nel cimitero), la porti nel cuore, c’è un dialogo continuo e sentiamo che in questa comunione, anch’essi pregano per noi, intercedono, chiedono quello che noi non riusciamo a vedere, impetrano quello che a noi non sembra essere bene, ma che agli occhi di Dio (perché i defunti ci vedono con gli occhi di Dio) è l’unico bene da perseguire.
In terza istanza, questa Celebrazione, questa commemorazione dei defunti è un’attestazione di fede nella vita eterna. La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci conforta, ci guida, ci sostiene.
Nel Libro di Giobbe, dove un uomo è fatto oggetto di ogni tipo di ingiustizia, sembra (sulle prime) anche da parte di Dio. Dopo le prime battute dove l’autore, il protagonista sia pure simbolico chiede che le sue parole vadano al di là di sé, possano essere tramandate (“Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero su un libro…”) c’è questa meravigliosa attestazione di questa fede nella vita eterna: “Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro”. Nel pieno della sofferenza, della delusione, dell’essere tradito da tutti, dalla natura, e apparentemente anche da Dio, Giobbe grida la sua speranza attraverso i cieli: quest’uomo disperato è portatore di una grande speranza che Gesù attesterà con l’autorità unica che è quella di Dio (“Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere”). Bella questa immagine di polveri: sono le polveri della storia, oltre che quelle prodotte dalle nostre ossa polverizzate. “Ultimo si ergerà sulla polvere”: ma questo Dio vivo, perché si ergerà sulla polvere? Voi starete pensando: per umiliare quest’uomo che è tornato polvere. Ricordate l’espressione del Qoèlet? “Ricordati uomo che sei polvere e in polvere ritornerai”. No, non è questa la lettura giusta. Non è una sorta di trionfo del Dio sulla polvere – tutto è polvere ma Dio è vivo – ma è una sorta di protezione di Dio su queste polveri sante che sono le polveri della storia, la mia polvere, la tua polvere, la polvere delle strade, la polvere delle culture che si sono sgretolate, delle città disabitate di cui non rimarrà pietra su pietra, come dirà Gesù nei discorsi apocalittici del Vangelo. Su questa polvere il mio Redentore vivo si ergerà, quasi a protezione. Non è il custode del cimitero della storia, Dio, ma è Colui che raccoglie queste polveri e le rimpasta come all’inizio per una nuova, definitiva e finalmente riuscita creazione che certamente è diversa da quella attuale ma è in continuità, perché se non ci fossero le mie polveri, Egli non potrebbe riformare la mia vita, il mio corpo, i miei giorni, i miei sentimenti, i miei affetti. Allora questo Dio che si erge non è – come dice una poesia di un autore del Novecento poco conosciuto – triste come un Dio che sorga sulle rovine degli altari infranti. Qui è il Dio disperato che vede l’altare a Lui dedicato sconsacrato, distrutto, ma è il Dio che viene a coprire con la sua coltre queste polveri e a covarle di nuovo perché rinasca la vita. Poi c’è questa attestazione fortissima: “Dopo che questa mia pelle sarà strappata via…”. E qui il richiamo – ma accadrà dopo 2500 anni – è a San Giovanni della Croce che – e lo sanno bene le monache che conoscono questo autore del Cinquecento, grande mistico – a proposito, dice: “Strappa la tela al nostro dolce incontro”. Questa pelle diventa la tela che separa l’amato dall’amata, questa tela dev’essere lacerata perché l’amore non riesce a sopportare più indugio. Quindi questa immagine di distruzione diventa un’immagine di risurrezione, la pietra che è scalzata, portata lontano come una foglia perché quando questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne – noi diremmo: con la mia carne gloriosa – vedrò Dio. Io, io stesso lo vedrò, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Mi piaceva di più la traduzione precedente: purtroppo siamo nostalgici anche delle parole (per fortuna). “I miei occhi lo contempleranno non da straniero”, cioè non lo vedrò come un nemico, come un estraneo, ma lo vedrò con gli occhi dell’amore, perché è mio Padre, perché mi dirà: “Tu sei mio figlio, ti ho aspettato a lungo. Finalmente ci guardiamo negli occhi”.
Questa è l’esperienza della morte nella visione cristiana, dove Dio si rivolge a noi e noi lo guardiamo, e non da straniero: non ne avremo timore, non avremo paura d’esser condannati perché tutti ci presenteremo laceri al Suo cospetto. “Non si cammina impunemente in questa vita”, dice l’autore de “L’imitazione di Cristo”. Io lo vedrò, i nostri defunti già lo vedono e noi lo vediamo attraverso i loro occhi e diciamo: adorate per noi quel Dio che noi intravediamo nei vostri occhi, che abbiamo intravisto nel vostro affetto, nella delicatezza, nell’attenzione che avete avuto per noi. Pregate per noi, perché giungiamo a questo incontro e perché questa lacerazione della tela, della pelle, questa distruzione, questa polverizzazione della vita non ci sia eccessivamente d’intralcio. Mi piace concludere, ma cito un po’ come mi viene in questo momento, perché mi raggiunge in questo istante questa sollecitazione, con quell’atto di fede di Ungaretti rispetto alla madre che egli vede, ma non si sono ancora guardati, madre e figlio. Così immagina il poeta questo incontro con sua madre, quando cadrà il muro d’ombra e la madre lo prende per mano:
Come una volta mi darai la mano.
In ginocchio, decisa,
sarai una statua davanti all’eterno,
come già ti vedeva
quando eri ancora in vita.
C’è questa immagine della madre inginocchiata che prega, che è rimasta nella mente del poeta adesso adulto, ma che appartiene all’imprinting della fede:
E solo quando m’avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.
La madre attende che Dio cancelli dagli occhi del figlio quanto la vita gli ha offuscato “e solo quando m’avrà perdonato ti verrà il desiderio di guardarmi. Ricorderai d’avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro”. Bello anche metterci alla scuola dei poeti per percepire come queste antenne dell’umanità hanno sentito che la vita eterna non è una fiaba. Coraggio, fratelli e sorelle: ci aspettano grandi cose. Sopportiamo – come dice la parabola – il peso della giornata e del caldo. Alla fine, in fondo alla strada, in fondo alla vita, dopo il tramonto di questo giorno bello, tremendo e meraviglioso, ci aspetta Dio con le braccia aperte”.